
LE RAGIONI DELLA COMUNITÀ
Introduce e coordina
MASSIMO BELOTTI, Direttore di “Biblioteche oggi”
ANNALISA CICERCHIA, Economista della cultura – ISTAT, Vice Presidente Cultural Welfare Center – L’impatto delle biblioteche su benessere e salute
ROSSANA MORRIELLO, Servizio Programmazione Sviluppo e Qualità, Politecnico di Torino
Noam Chomsky nel suo discorso sul Bene Comune individua le biblioteche come uno degli esempi di strutture sociali importanti poiché rivolte a tutti e non soltanto alle classi benestanti e colte, in grado quindi di offrire un’opportunità per colmare i divari sociali e culturali. Nella società contemporanea, fondata sul modello del capitalismo sociale, le biblioteche sono tra le poche istituzioni che incarnano il concetto di Bene Comune. Le origini del concetto si collocano nell’antica Grecia – per Aristotele il bene comune era l’obiettivo della democrazia – poi per molti secoli il dibattito sul Bene Comune è stato marginalizzato. A partire dalla seconda metà del XX secolo il tema è tornato ad essere centrale nelle riflessioni rivolte a prefigurare un modello alternativo al capitalismo sociale imperante, i cui effetti in termini di diseguaglianze sono traslati, e a volte esasperati, nel mondo digitale. Tale modello alternativo è basato sulla cooperazione, sul rafforzamento delle relazioni all’interno di comunità solide, sulla capacità degli individui di costruire nuove regole per una società sostenibile e verso un nuovo Umanesimo che riporti al centro i valori umani fondamentali.
Le biblioteche sono esse stesse beni comuni materiali in quanto servizio di pubblica utilità, ma sono anche custodi di un bene comune immateriale, la conoscenza, come accumulata nel corso della storia dell’umanità e depositata su supporti analogici e digitali. Per il tramite delle biblioteche, la comunità, senza alcuna forma di discriminazione, può accedere al patrimonio di conoscenza che gli è proprio, in quanto bene comune. La sfida per le biblioteche è oggi continuare a salvaguardare il bene comune della conoscenza, contribuendo a mantenere le comunità coese e solide, garantendo un accesso alla conoscenza aperto, inclusivo, sostenibile, in qualsiasi formato si presenti, e soprattutto contrastando le limitazioni al carattere pubblico della conoscenza che il digitale spesso introduce.
SIMONA VILLA, Studio 2di2 – Il Design thinking come strumento innovativo nel rapporto con la comunità
ANNA MARIA TAMMARO, Direttore Digital Library Perspectives – Tra prossimità e distanza: i servizi delle biblioteche partecipative e inclusive
Le biblioteche partecipative sono sistemi che consentono alle comunità di diventare realmente partecipi del disegno e gestione dei servizi e rendono possibile l’estensione all’ambiente digitale del concetto di biblioteca centro di comunità (o anche centro di incontro, centro di apprendimento, media center, centro informativo, centro di creatività ecc.). I bibliotecari, con la loro deontologia, i loro valori, la loro conoscenza delle infrastrutture, hanno la potenzialità di migliorare le comunità e per il disegno dei servizi devono comprendere il livello tecnologico, il livello organizzativo, il livello politico ed etico.
ANTONELLA AGNOLI, Consulente Bibliotecaria – Progettare la biblioteca insieme ai cittadini
Se c’è oggi un compito urgente per tutti gli operatori della cultura è quello di far emergere l’intelligenza collettiva troppo spesso mortificata dalla politica e dalla burocrazia. Per fortuna oggi le pratiche di coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbliche sono sempre più diffuse anche se non sempre efficaci.
È necessario costruire luoghi appropriati di dibattito, interagire in contesti di dialogo basati sulle regole del confronto creativo: in questo tipo di processi i cittadini sono felici di dare il loro contributo, di sentirsi coinvolti e partecipi. Per le istituzioni e gli operatori che li promuovono sono fonte di creatività, di espressione di bisogni essenziali, di dialogo e di collaborazione nella ricerca di soluzioni, spesso inedite, efficienti, gradite. Questo richiede una politica ma soprattutto una pubblica amministrazione che non escluda, aperta al dialogo, dialogante, concreta, non chiusa nella difesa di procedure ossificate, mal concepite, talvolta insensate. Al contrario, le regole di funzionamento della biblioteca possono sicuramente diventare un terreno di confronto e lavoro con i cittadini. Molte esperienze ci dicono che gran parte dei successi e degli insuccessi delle politiche pubbliche amministrazioni stanno proprio nella capacità o incapacità di collaborazione fruttuosa con i cittadini, che dipende soprattutto nella sburocratizzazione della pubblica amministrazione.
Nessuno vuole passare dal pubblico al privato, nessuno vuole delegare responsabilità politiche, ma ormai è veramente necessario dare spazio ai cittadini e consentire loro di affermare un ruolo nella costruzione di nuove forme di democrazia. Oggi senza un’amministrazione inclusiva e capace di dialogo non è possibile migliorare nessun servizio pubblico: dai trasporti alla riqualificazione di una piazza, dalla costruzione alla riprogettazione di una biblioteca, dal recupero di un edificio abbandonato alla cura di un territorio. Questo può avvenire soltanto attraverso un processo di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, possibilmente non limitato solo alla fase del pre-progetto ma portato avanti nel tempo fino ad arrivare a forme di gestione co-partecipata.
Dobbiamo pensare alle biblioteche come luoghi dove tessere relazioni, dove riflettere su quale servizio è necessario in quella comunità. Il modello di biblioteche basate sui servizi uguali per tutti è superato: abbiamo bisogno di nuovi approcci, di servizi personalizzati, perché prossimità è qualità della vita, qualità delle relazioni umane. Lavorare con la comunità significa essere consapevoli delle diversità, ancora più accentuate dalla pandemia, dagli accessi on line, della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il Covid-19 ha costretto tutti a immaginare modi nuovi di gestione dei nostri servizi. Abbiamo reagito inventandoci servizi che hanno interagito con le singole persone. Ora dobbiamo non disperdere questo capitale di relazioni positive e trasformarle in un coinvolgimento della comunità nel ripensare i servizi bibliotecari: ne parleremo attraverso alcune esperienze italiane e straniere.
FRANCESCO GIUSEPPE MELITI, Biblioteca Universitaria di Lugano – Diversità, equità ed inclusione in biblioteca: per una cura della comunità e del pianeta
Sia che si parli di sostenibilità sociale “interna” o di sostenibilità sociale “esterna”, la questione in realtà riguarda sempre l’equità e la giustizia intergenerazionale e intragenerazionale, una giustizia sociale come valore imprescindibile anche per le biblioteche, le quali non si possono chiamare fuori, chiudendosi nella “turris eburnea” di una pura mediazione informativa.
Negli ultimi anni in ambito bibliotecario statunitense l’attenzione è stata posta sempre di più verso le tematiche relative alla “Diversità, Equità e Inclusione” (Diversity, Equity and Inclusion), identificate appunto tramite l’acronimo DEI, con un attivismo ed un filone di studi e ricerche che riguardano non sole le biblioteche pubbliche ma anche quelle delle università. Ad es. tra gli ultimi volumi pubblicati il seguente riguarda proprio le biblioteche delle università USA: Diversity, equity, and inclusion in action : planning, leadership, and programming, edited by Christine Bombaro, Chicago, ALA Editions, 2020.
Questi studi riguardano non solo le attività ed i servizi delle biblioteche, ma anche le “diversità” rappresentate ad esempio nelle collezioni.
Se le biblioteche italiane, in particolare quelle pubbliche, sono alla fine rimaste aperte, unico servizio pubblico culturale, anche in zona rossa durante le fasi più buie della pandemia, forse questo è stato dovuto alla percezione di una loro essenzialità, anche nel prendersi cura delle persone e delle loro necessità, non soltanto di quelle strettamente informative.
Il tutto nel solco di un “lavoro di cura”, la cui indispensabilità è emersa prepotentemente durante la pandemia e di cui dovremmo far tesoro nel realizzare un futuro più sostenibile per il nostro pianeta e per tutte le persone che lo abitano, come afferma anche il “Manifesto della cura : per una politica dell’interdipendenza” (Care Manifesto: the Politics of Interdependence, Verso Books, 2020).
Per attuare questo lavoro di cura la biblioteca dovrebbe sempre più “allinearsi” ed “essere prossima” alle esigenze della propria comunità, non in termini astratti e generali, ma specifici per i singoli membri delle comunità servite, a partire dalle loro diversità.
-
Massimo Belotti
Direttore di “Biblioteche oggi”
-
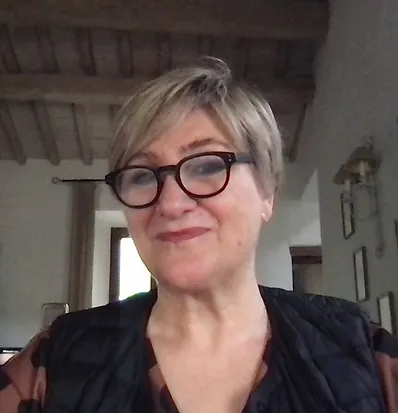
Annalisa Cicerchia
Vice Presidente Cultural Welfare Center (CCW)
-

Rossana Morriello
Università di Firenze, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo
-

Simona Villa
Studio 2di2
-

Anna Maria Tammaro
Editor in Chief Digital Library Perspectives
-

Antonella Agnoli
Consulente per progettazione spazi culturali
-

Francesco Giuseppe Meliti
Università della Svizzera italiana - Biblioteca universitaria Lugano