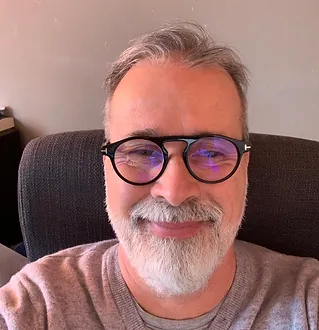LE ACQUISIZIONI IN BIBLIOTECA: ESPERIENZE, METODI, ATTORI
Sessioni a cura dei gruppi di lavoro con il coordinamento della direzione scientifica
GIULIANA CASARTELLI, Responsabile Area biblioteca, cultura e politiche giovanili, Comune di Olgiate Comasco
FRANCESCO GIUSEPPE MELITI, Biblioteca Universitaria di Lugano
Il questionario lombardo sull’utilizzo dei fondi ministeriali: un’occasione di conoscenza per le pratiche di acquisto in biblioteca
Questa relazione prende in considerazione lo stanziamento del Ministero della Cultura di 30 milioni di euro a favore delle biblioteche pubbliche per l’acquisto di libri presso le librerie “di prossimità”, con alcune osservazioni derivanti dall’analisi dalle risposte ad un questionario relativo all’utilizzo del contributo erogato nel 2020.
Questo questionario era stato promosso dal Sistema Bibliotecario dell’Ovest Como, con l’adesione delle coordinatrici del Sistema bibliotecario della Brianza Comasca (CO) e del Sistema bibliotecario Valli dei Mulini (VA), al fine di compiere un monitoraggio sull’utilizzo dei fondi assegnati nel 2020 dall’allora MiBACT alle biblioteche pubbliche della Lombardia, regione rappresentante circa il 16% della popolazione italiana e destinataria complessivamente di ben il 25% di questi fondi (7.495.709,00 € su 29.999.991,00 €). Il questionario, composto di 27 domande, ha costituito anche un momento di riflessione o di auto-riflessione da parte delle bibliotecarie e dei bibliotecari relativamente ad una pratica di acquisto effettuata per la prima volta con questi fondi ed in vista di un rinnovo del finanziamento, come è avvenuto anche per il 2021 e per il 2022 e come sarà forse anche per il 2023.
Entro il termine di restituzione del questionario (metà di giugno 2021) avevano risposto 468 delle 1147 biblioteche lombarde che avevano ricevuto il contributo erogato dal MIBACT nel 2020.
SARA DINOTOLA, Università degli Studi di Torino
Per uno schema di corrispondenza tra le classificazioni editoriali e la CDD:
riflessioni preliminari a favore di uno sviluppo delle collezioni maggiormente data-driven
La selezione e l’acquisizione documentaria dovrebbero rappresentare l’approdo finale di un attento processo programmatico, finalizzato alla definizione dei criteri e delle linee guida da seguire in fase di sviluppo delle collezioni. A tal proposito, un ruolo importante è stato tradizionalmente attribuito all’analisi delle raccolte esistenti, da condurre sulla base di approcci e metodi differenti.
Sarebbe auspicabile rafforzare e ampliare questa cultura valutativa, adottando una prospettiva sempre meno autoreferenziale e in grado di favorire il dialogo tra i bibliotecari e gli altri attori della filiera del libro. In particolare, le riflessioni sulle collezioni non dovrebbero prescindere da una conoscenza approfondita da parte dei bibliotecari sia dell’offerta editoriale e dell’andamento del mercato, sia del modo in cui i relativi dati sono organizzati. Come è noto, i sistemi di classificazione dell’offerta editoriale (CCE e Thema) non corrispondono a quello utilizzato da quasi tutte le biblioteche pubbliche italiane, ossia la CDD: ciò comporta difficoltà di comunicazione tra i due mondi che non possono essere ignorate.
Il presente intervento intende offrire alcuni spunti metodologici per iniziare a mappare le due tipologie di linguaggi e giungere – al netto delle necessarie approssimazioni dovute alle differenze sostanziali che li contraddistinguono – alla definizione di uno schema di corrispondenza. Esso potrebbe essere utile per editori, fornitori e bibliotecari. Questi ultimi, ad esempio, avrebbero gli strumenti cognitivi per compiere ricerche più mirate nei database dei fornitori e in quelli editoriali, per effettuare utili benchmarking tra ciò che viene pubblicato e ciò che viene acquisito dalle biblioteche, nonché per valorizzare al meglio la bibliodiversità dell’offerta editoriale in fase di sviluppo delle collezioni.
DANIELE FORZAN, Leggere srl
Supporto digitale per lo sviluppo della collezione
Come fanno bibliotecari delle Biblioteche di Pubblica Lettura a selezionare i titoli per lo sviluppo della collezione? In effetti sembra una attività onerosa, complessa ed oltretutto comporta una grande responsabilità: scegliere tra le oltre 85.000 novità (dato novità 2021) quei titoli più adatti alla biblioteca, disponendo di un budget limitato, in grado di coprire solo l’1.8 % della produzione. Inquadriamo meglio l’argomento con alcuni dati: titoli acquistati in media annualmente da una biblioteca di pubblica lettura 600, media annuale produzione titoli novità “adatti” alle biblioteche di pubblica lettura 27.000, titoli novità di narrativa pubblicati settimanalmente 193, titoli di narrativa mediamente acquistati settimanalmente dalle biblioteche di pubblica lettura 5. Come si fa a selezionare i 5 titoli di narrativa più adatti ad una biblioteca tra 193 titoli prodotti in una settimana? Si utilizzano degli algoritmi esperienziali conditi da innumerevoli bias: insomma ci pensano i bibliotecari. Funziona? A volte sì ma forse è più corretto dire che nella maggior parte dei casi non lo sappiamo. Come si misura la performance di una collezione? Ma soprattutto lo si fa? Regolarmente? Con quali tecniche? In presenza di performance insoddisfacenti, si utilizza la misurazione per modificare gli algoritmi esperienziali conditi da bias?
Con questo intervento vorremmo provare a dimostrare come gli strumenti digitali sono in grado di aiutare il bibliotecario nel migliorare le performance della collezione. Utilizzeremo big data, machine learning, algoritmi, statistiche di acquisto, statistiche di prestato e i preziosissimi metadati bibliocatalografici.