
BIBLIOTECHE ACCADEMICHE: SCENARI E TENDENZE
Coordina
GIOVANNI SOLIMINE, Direttore del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, La Sapienza Università di Roma
Indirizzo di saluto
STEFANO RUFFO, Coordinatore Commissione Biblioteche della CRUI, Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste
ORIENTAMENTI
MAURO CALISE, Professore ordinario di Scienza politica, Direttore di Federica Weblearning, Università degli studi di Napoli Federico II
Ecosistema digitale, università e infrastrutture della conoscenza
Lo tsunami Covid ha sdoganato la digital education in ogni angolo del pianeta. L’open learning – spazi ed accessi liberi per l’apprendimento – è lo scenario che i nativi digitali sentono come più consono alle proprie aspettative, linguaggi, stili di vita. Cambiando l’agenda politica, all’insegna della generazione Greta.
La domanda non è più se l’università debba aprirsi al digitale, ma con che forme, tecnologie, strategie debba affrontare questa nuova frontiera. I MOOC – Massive Open ONine Courses – hanno rappresentato il re-branding dell’elearning, la scoperta che la distance education può raggiungere standard qualitativi altissimi e a costi incomparabilmente minori rispetto all’insegnamento brick & mortar. Ma queste straordinarie potenzialità non avevano ancora sfondato nel senso comune, e nell’esperienza viva della maggioranza degli studenti. Dopo l’accelerazione drammatica di quest’anno, #iostudioacasa è diventata una pratica quotidiana di massa. Con un lascito di sperimentazioni e aspettative per la governance di tutti gli atenei – e dei governi. E la richiesta di un salto di consapevolezza e di know-how per affrontarle.
ROBERTO DELLE DONNE, Professore ordinario di Storia medievale, Coordinatore Gruppo SHARE (Scholarly Heritage and Access to Research)
Cooperazione bibliotecaria e scienza aperta: destini incrociati?
In Europa e nel mondo, anche per impulso delle politiche della Commissione Europea e degli enti finanziatori della ricerca, sono state avviate negli ultimi anni numerose iniziative per promuovere la scienza aperta. La possibilità di accedere gratuitamente e liberamente all’intero ciclo della ricerca scientifica e ai suoi risultati senza dover sostenere costi di abbonamento è uno degli obiettivi principali dell’Open Science, sulla cui importanza insistono le raccomandazioni della Commissione Europea a partire almeno dal 2007, fino alla recente individuazione di tre grandi aree di intervento (Open access to publications, Open research data e Open scholarly communication) e alla proposta di implementazione di una Road Map per la realizzazione dello European Science Cloud, fatta propria dai ministri dell’Unione europea il 29 maggio 2018. Mai come oggi, nella crisi che ha colpito il mondo intero, è stata avvertita l’esigenza di avere libero accesso ai dati scientifici e ai risultati della ricerca.
Quale ruolo possono avere i sistemi bibliotecari nel promuovere la scienza aperta? La lunga tradizione di esperienze di collaborazione e, soprattutto, di cooperazione interbibliotecaria, avviate già negli anni Ottanta del secolo scorso, può essere rinnovata e attualizzata per dare vita a infrastrutture di sostegno alla scienza aperta? Secondo quali modelli organizzativi e di coordinamento e/o di integrazione? Nel mio intervento cercherò di dare risposta a questi interrogativi sulla base dell’esperienza di Universities Share (Scholarly Heritage and Access to Research), la piattaforma di accesso ai servizi bibliotecari condivisi dalle Università degli Studi della Basilicata, Campania “L. Vanvitelli”, Napoli Federico II, Napoli L’Orientale, Napoli Parthenope, Napoli “Suor Orsola Benincasa”, Salento, Salerno, Sannio.
FEDERICO MESCHINI, Ricercatore di Informatica applicata alle discipline umanistiche, Università degli studi della Tuscia
What’s in a [Library|Platform]? Trasversalità e intersezioni nell’infosfera
Il concetto di piattaforma è uno dei principali fulcri che hanno reso possibile l’evoluzione del World Wide Web da strumento per la pubblicazione di ipertesti a infrastruttura comunicativa e conoscitiva globale. L’utilizzo degli standard e l’interoperabilità tra le varie componenti è ciò che caratterizza una piattaforma. Questi stessi tratti distintivi si ritrovano anche negli ambienti informativi di qualsiasi genere, includendo perciò le biblioteche. Ciò è però solamente un primo livello, in quanto sulla base tecnologica si innesta una componente socioculturale che a sua volta interagisce con quella sottostante, dando così vita ad una continua interazione reciproca, che rende non banale comprendere pienamente i mutamenti in atto. Per questo motivo la biblioteca deve essere sì una piattaforma, come di fatto è, nel senso più astratto e generale del termine, ma al tempo stesso, a causa della sua natura e missione, si ritrova nella non semplice situazione di dovere riequilibrare gli squilibri e le numerose criticità create o amplificate dalle principali piattaforme digitali, di cui i disordini informativi sono la manifestazione più evidente.
LUIGI MOSCHERA, Professore ordinario di Organizzazione aziendale, Pro Rettore alla Terza Missione, Università degli studi di Napoli Parthenope
La Terza missione delle università e il ruolo delle biblioteche
Il ruolo delle biblioteche accademiche nelle cosiddette Attività di Terza Missione delle Università è sicuramente ormai consolidato e negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza dell’importanza dello stesso nella comunità scientifica internazionale.
La conservazione e valorizzazione dei beni pubblici, del patrimonio culturale, la produzione di beni pubblici di natura sociale ed educativa, le iniziative di public engagement e i più recenti strumenti a sostegno dell’Open Science sono solo alcuni dei “campi d’azione” in cui si possono ritrovare iniziative rientranti nella mission e nei servizi delle biblioteche universitarie. In Italia, il dibattito sul “come” e “in quale campo di azione” collocare i servizi bibliotecari e sul “rileggerli” e catalogarli come attività di Terza Missione è ormai giunto a uno stadio di maturità, anche grazie a recenti pubblicazioni e a numerosi interventi a convegni o ai seminari dedicati al tema e organizzati dalla comunità bibliotecaria. Non altresì maturo e ancora povero di contributi consolidati, legittimati e soprattutto accreditati dalla comunità bibliotecaria è il tema della misurazione, della valutazione dell’impatto economico, sociale, culturale prodotto da tali iniziative. Vi è effettivamente una necessità di procedere con la valutazione e con l’autovalutazione delle attività bibliotecarie di Terza Missione? Quali possono essere indicatori utili per misurare l’impatto delle iniziative prodotte? L’impatto delle iniziative delle biblioteche universitarie in ambito di Terza Missione è comparabile o posizionabile in una scala di valori con le altre iniziative di Terza Missione universitaria, come ad esempio quelle legate al trasferimento tecnologico? Questi sono solo alcuni degli interrogativi che animano l’attuale dibattito sulle attività delle biblioteche accademiche per la Terza Missione.
RAFFAELE DE MAGISTRIS, già Direttore della Biblioteca universitaria di Napoli
Se una Biblioteca Universitaria guarda al territorio
Negli ultimi anni, soprattutto a partire dalla conclusione nei lavori di ammodernamento e ristrutturazione che l’hanno interessata per oltre un decennio, la Biblioteca Universitaria di Napoli si è aperta decisamente al territorio circostante. Due i fattori che hanno inciso maggiormente. In primo luogo è profondamente mutato il contesto interno all’Università Federico II e alla sua rete di servizi bibliotecari, sviluppatasi enormemente, ma in modo autonomo rispetto alle politiche dell’odierno MIC (basti pensare al divergere delle scelte in materia di SBN). Per altro verso ha subito profonde trasformazioni il tessuto urbano intorno alla Biblioteca, che ha visto la rinascita sotto vari aspetti del Centro storico, cui ha fatto da corollario anche una forte presa di coscienza civile rispetto agli storici fenomeni di degrado e malavitosi. Un Centro storico su cui grava però l’assenza di una biblioteca pubblica comunale. Pertanto, in questi ultimi anni l’orizzonte di riferimento, il paradigma di servizio a cui guardare è parso sempre più quello della biblioteca pubblica, nella versione, frequente in Italia, di una biblioteca pubblica dalla “storia antica”. L’intervento vuole proporre una prima riflessione su questa esperienza, di cui si cerca di mettere in evidenza aspetti positivi, criticità e limiti. Ne emerge uno scenario sfaccettato, all’interno del quale, tuttavia, alcuni elementi cardine paiono ineludibili, primi fra tutti l’individuazione di modelli gestionali e offerte di servizi capaci di coinvolgere fasce di pubblico molto più ampie di quelle tradizionali e la collaborazione con tutti gli attori culturali e sociali attivi sul territorio.
DISCUSSIONE
-

Giovanni Solimine
Professore Emerito Sapienza Università di Roma
-
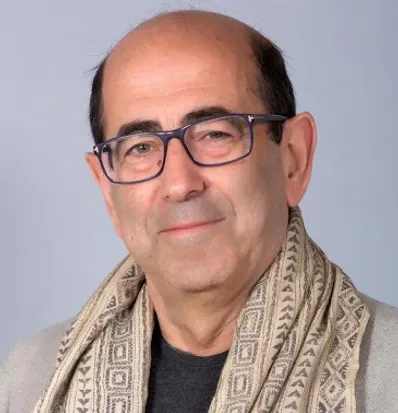
Mauro Calise
Professore ordinario di Scienza politica, Direttore di Federica Weblearning, Università degli studi di Napoli Federico II
-
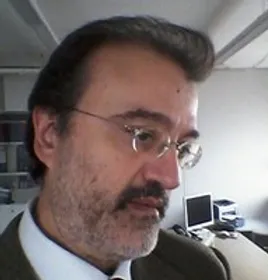
Roberto Delle Donne
Professore ordinario di Storia medievale, Coordinatore Gruppo SHARE (Scholarly Heritage and Access to Research)
-

Federico Meschini
Ricercatore di Informatica applicata alle discipline umanistiche Università degli studi della Tuscia
-

Luigi Moschera
Professore ordinario di Organizzazione aziendale, Pro Rettore alla Terza Missione, Università degli studi di Napoli Parthenope
-

Raffaele De Magistris
già Direttore della Biblioteca universitaria di Napoli