
SCENARI E TENDENZE
LAURA MORO, Direttore dell’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale – Digital Library, Ministero della Cultura
Il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale: strategie e opportunità
Il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale costituisce la visione strategica attarverso cui il Ministero della Cultura intende innescare, facilitare e accelerare i cambiamenti strutturali che l’innovazione tecnologica abilita in tutto il settore culturale. Essa verrà attuata nel quinquennio 2022-26, secondo fasi che definiranno gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, identificando le metriche di valutazione dei risultati raggiunti e il monitoraggio delle azioni programmate.
Gli step previsti dalla Digital Library in questo grande processo di trasformazione sono due: in primo luogo, ampliare la quantità di patrimonio digitale disponibile online; in secondo luogo, estendere le forme di accesso al patrimonio, per costruire su di esso percorsi di senso, di fruizione e di valorizzazione. In questa prospettiva si colloca la realizzazione di una grande infrastruttura nazionale per la raccolta, la conservazione, l’indicizzazione e l’offerta dei contenuti culturali: un ecosistema interdipendente, un ambiente collettivo e condiviso (anche attraverso la co-creazione e il crowdsourcing), una rete che abiliti scambi, non solo di risorse, ma anche di tecnologie e saperi, processi e buone pratiche.
Un grande cambiamento di paradigma, dunque: l’ambiente digitale non è una trasposizione in bit di un mondo analogico, ma è un ambiente che ha nuove regole, nuovi linguaggi, nuove tecnologie. Per questo motivo, è prevista la realizzazione di un programma di “Formazione e aggiornamento delle competenze”, che tiene conto della formazione come uno dei fattori fondamentali per la realizzazione della transizione digitale.
GIOVANNI BERGAMIN, Comitato Esecutivo Nazionale, Associazione Italiana Biblioteche
Biblioteche e comunità digitali
Le tecnologie del web semantico e dell’intelligenza artificiale promettono miglioramenti radicali nel nostro modo di ‘stare al mondo’ e sono anche (non da oggi) tra le tecnologie più discusse. Per l’intelligenza artificiale si è parlato di tecnosciovinismo ovvero della convinzione che una soluzione tecnologica ai problemi sia sempre la soluzione migliore. L’attualità del famoso modello a strati del web semantico, chiamato anche ‘torta a strati’ – proposto da Tim Berners Lee nel 2001 – è stata messa in discussione nell’ultima conferenza internazionale sul tema (ISWC2022). Nella sua relazione introduttiva Markus Krötzsch ha sottolineato che quel grafico va aggiornato aggiungendo un nuovo strato di base (o fondante): la comunità. Si può sicuramente concordare sul fatto che il successo del web semantico dipende da quello che le differenti comunità coinvolte riusciranno a fare per mettersi d’accordo sugli obiettivi, sui ‘significati’ delle regole, sui contenuti concettuali delle entità che sono in gioco nei servizi che vengono offerti. E la stessa cosa si può dire per l’intelligenza artificiale. È bene sottolineare che qui ‘mettersi d’accordo’ significa scambio diretto (discussione, trattativa) tra esseri umani: le macchine che si scambiano ‘triple’ o che usano raffinati algoritmi vengono dopo. Le comunità coinvolte potrebbero essere chiamate comunità digitali non tanto in quanto comunità appartenenti alla ‘infosfera’, ma in quanto comunità in grado di determinare in ultima analisi il successo di queste tecnologie. È importante discutere quali siano le comunità digitali coinvolte e quale sia il ruolo in questo contesto delle biblioteche.
ZÉLIA PARREIRA, Chair EBLIDA LIBLEG-Expert Group on Library Legislation and Policy in Europe
Quale politica europea per le biblioteche pubbliche: le nuove Council of Europe/EBLIDA Guidelines
In 2000, EBLIDA and the Council of Europe adopted the Guidelines on Library Legislation and Policy in Europe. This instrument supported and, in some ways, helped to shape the formulation of the legislation enacted since then in the library sector.
During these twenty years, society has undergone changes that were unimaginable at the turn of the century and, as a result, the needs of users and the service provided by libraries has also changed. Although the relevance of the issues addressed in the 2000 guidelines remains, EBLIDA found necessary to update them, as a guiding instrument, allowing new issues such as sustainability or the role of libraries in situations of local, regional, or global crisis, to be added to the traditional concerns: the functioning of libraries, the availability of resources or the regulation on access and use of information.
Therefore, in 2022, EBLIDA formulated a proposal for new guidelines, whose approval and adoption by the Council of Europe is now being made official. The topics covered reflect current concerns and seek to meet the needs expressed by European librarians in the frequent consultations that EBLIDA has undertaken.
In this context, the communication now presented aims to make known:
a) the process of reflection and work that led to the formulation of the new Council of Europe/EBLIDA Recommendations on library policy and legislation in Europe
b) The content of the Recommendations
c) Prospects for the applicability of the Recommendations
CLAUDIO LEOMBRONI, Dirigente Area Biblioteche e Archivi, Regione Emilia-Romagna
Le biblioteche italiane di prossima generazione: le opportunità del PNRR e dei fondi europei
Nella parte introduttiva dell’intervento sono focalizzate le principali criticità che incombono sulle biblioteche italiane e le possibili traiettorie di cambiamento in una prospettiva di lungo periodo. Di seguito sono analizzati gli impieghi delle risorse del PNRR e dei fondi strutturali e di investimento europei delle Regioni a favore delle biblioteche e la loro effettiva capacità di disegnare le prossime generazioni di biblioteche.
ANNALISA ROSSI, Soprintendente ai beni archivistici e bibliografici della Lombardia, del Veneto e del Trentino Alto Adige, Ministero della Cultura
PNRR in azione: quale governance per quale efficacia
Muovendo da una sintetica ricognizione delle misure e delle componenti del PNRR destinate al settore culturale e, in particolare, all’area delle biblioteche e degli archivi (Cultura e Innovazione per la PA), il paper rende conto di alcune istantanee del Piano, colto nella sua fase esecutiva e nei processi generatisi ai diversi livelli istituzionali per tradurlo in azione. La cosiddetta ‘messa a terra’ del PNRR, osservata dall’interno e con sguardo consapevole, impone considerazioni di metodo, prima che di merito, allocandone il potenziale di efficacia nel centro esatto di ogni possibile innovazione della Pubblica Amministrazione (quali Biblioteche e Archivi destinatari degli interventi sono): la cultura organizzativa e manageriale. Si può parlare di innovazione prodotta in assenza di trasformazione dei modelli di gestione e di passaggio dal modello burocratico a quello collaborativo? Si può parlare di valore pubblico prodotto senza che i processi presupposti transitino da un impianto di government monodirezionale e tendenzialmente top-down a un impianto di governance plurale e multilivello, capace di internalizzare la rete come metodo di gestione della conoscenza? Secondo quali indicatori gli output e gli outcome attesi si qualificano in termini di valore pubblico generato, nel contesto di perimetri istituzionali e strumenti manageriali non definiti dalle misure? Cercando di rispondere a questi interrogativi, mettendo a fattore comune il bagaglio metodologico e pratico dell’azione di tutela del patrimonio, si affronteranno i temi delle competenze professionali e della cultura istituzionale quali condizioni abilitanti imprescindibili per l’uso efficace delle risorse, nel quadro più ampio degli obiettivi di sostenibilità e di equità declinati dall’Agenda 2030 e dai relativi strumenti attuativi a livello europeo e nazionale.
JEFF MIXTER, Senior Product Manager, Metadata & Digital Services, OCLC
Oltre il catalogo: nuove tecniche per conoscere la biblioteca
Libraries’ current data management workflows focus on cataloging and the tools that support the creation and maintenance of metadata for inventory management and data interchange. Over time, however, user behaviors and expectations have come to rely on smarter search algorithms (discovery) and on-demand access (delivery) of library resources. In response, libraries must shift how they manage and leverage data to meet evolving user needs. Next generation metadata—specifically Linked Data—is perfectly positioned to enable these data connections and empower both libraries and their users in the journey for information.
In this session, we’ll explore how new Library Knowledge Work supports cataloging and metadata management, but can also significantly impact areas tangentially related such as adding new contextual information to special collection and cultural heritage material and discovery improvement such as knowledge cards.
-

Laura Moro
Direttore dell'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library
-
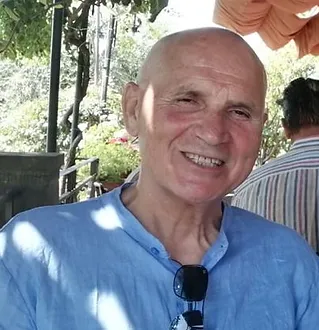
Giovanni Bergamin
Comitato Esecutivo Nazionale AIB
-

Zélia Parreira
Chair EBLIDA LIBLEG-Expert Group on Library Legislation and Policy in Europe
-

Claudio Leombroni
Dirigente Area Biblioteche e Archivi, Regione Emilia-Romagna
-

Annalisa Rossi
Soprintedenza archivistica e bibliografia della Lombardia
-

Jeff Mixter
Senior Product Manager, Metadata and Digital Services, OCLC