
LA NUOVA DIMENSIONE SOCIALE DELLA BIBLIOTECA
Sessioni a cura dei gruppi di lavoro con il coordinamento della direzione scientifica
Introduce e coordina
FERRUCCIO DIOZZI, Consulente bibliotecario, già responsabile del Centro di documentazione del CIRA-Centro italiano ricerche aerospaziali
Riflessioni sul tema
CHIARA FAGGIOLANI, La Sapienza Università di Roma
ANTONELLA AGNOLI, progettista culturale
ROBERTA FRANCESCHINELLI, Presidente Lo Stato dei Luoghi
Gli spazi del possibile
Nel corso degli ultimi dieci anni, si è assistito in tutta Italia alla diffusione di nuovi centri culturali multidisciplinari e ibridi in cui si sperimentano linguaggi e si indaga il contemporaneo fuori dai contesti tradizionali. Sono luoghi in cui convivono spazi per la produzione artistica, biblioteche di territorio, coworking, atelier di artigiani, sale per concerti o per il teatro, contesti di attivazione e riattivazione che recuperano siti abbandonati e dismessi, rigenerandoli e restituendoli alle comunità. Presìdi di un’innovazione non solo culturale, ma anche sociale e civica che, offrendo attività eterogenee e ambienti multifunzionali, facilitano relazioni tra persone differenti, attuano alleanze e sperimentano partnership inedite, non sempre facili, fra pubblico/privato /terzo settore/cittadini per la rigenerazione come azione comune. Esistono, e quali sono, le opportunità di collaborazione, sinergia e rete fra questi spazi culturali e le biblioteche in Italia oggi?
ANGELO CARCHIDI, progettista urbano e culturale
FaRo una fabbrica dei saperi a Rosarno
Il racconto di FaRo, esperienza progettuale di rigenerazione della biblioteca comunale di Rosarno, è l’occasione per illustrare le criticità che affrontano le biblioteche nei contesti periferici (dalla sostenibilità economica ai diritti all’accesso culturale) e per illustrare gli strumenti utilizzati dal team di lavoro per promuovere il libro e la lettura, per riattivare una biblioteca in disuso, per rendere un luogo di cultura in uno spazio di comunità.
GIUSEPPE PERNA, Associazione Annalisa Durante
Annalisa Durante. Una biblioteca a porte aperte per la ri-generazione
La Biblioteca a porte aperte Annalisa Durante è una biblioteca di frontiera, gestita da un’associazione anticamorra all’interno dello Spazio Comunale Piazza Forcella, intitolata ad una giovane vittima innocente della criminalità organizzata. Come le piazze erano il luogo dell’incontro, dello scambio, dell’esercizio della democrazia e del dialogo tra culture, così è la nostra Biblioteca: un luogo fronte strada, a porte aperte, dove chiunque può entrare, visitare, prendere un libro, leggerlo, scambiarlo con un altro, incontrare persone, partecipare ad attività laboratoriali, formarsi, ri-generarsi. Numerose sono le opportunità: dalla lettura 0-6 ai laboratori educativi e di inclusione per bambini, giovani e famiglie. Le attività sono inserite in un programma organico ed integrato che punta a promuovere un cambiamento nel nome di Annalisa Durante, in rete con istituzioni, scuole, biblioteche, editori, commercianti, associazioni. In un momento storico come questo, in cui occorre uscire più forti dalla pandemia, la nostra Biblioteca sta assumendo una nuova dimensione sociale in risposta agli obiettivi indicati dalla Next Generation EU, al fine di rendere la nostra comunità più responsabile e, in particolare, più verde, più digitale e più resiliente.
ROBERTO DI PUMA, Fondazione Terzoluogo
Fondazione Terzoluogo, spazi culturali educativi per le comunità del quartiere San Siro di Milano
“Per educare un bambino ci vuole un intero villaggio”
La fondazione Terzoluogo è impegnata nelle costruzione di un centro culturale-educativo in un luogo abbandonato e in via di recupero al centro del Quartiere San Siro di Milano .
Al centro del progetto la cultura come leva di cambiamento e la costruzione di una nuova biblioteca come fulcro di un luogo accogliente e inclusivo, attorno a cui sviluppare le altre attività dedicate al quartiere e in particolare quelle rivolte alla genitorialità e ai bambini nella fascia 0-6.
Il centro culturale-educativo di via Paravia 22 sarà concepito come una “piazza” aperta e comunitaria che riunisce diversi linguaggi, ambiti di scoperta, apprendimento e conoscenza attraverso due aree funzionali che operano in stretta sinergia, promuovendo l’incontro, l’ascolto e il dialogo tra culture, età e persone differenti: una biblioteca multimediale e un’area per l’Infanzia, coadiuvate e integrate da spazi laboratoriali di didattica, gioco e attività polivalenti, per adulti e bambini.
L’intervento si inserisce nel più ampio programma “Terzoluogo”, che intende sviluppare due progetti in due diverse città, Milano e Napoli, realizzando interventi e azioni volte a favorire l’integrazione e la coesione sociale, la cultura, il contrasto delle povertà educative. Tali progetti interesseranno soprattutto quei quartieri che vivono in modo più duro le conseguenze delle crescenti disuguaglianze, mettendo al centro lo sviluppo dei saperi individuali, collettivi e comunitari. Perché la cultura non è solo un’àncora nel mutare vorticoso delle cose; è anche una finestra di opportunità, la generazione di nuovi spazi di cittadinanza, l’invenzione di altre traiettorie del possibile.
Nella città contemporanea si assiste alla progressiva scomparsa di luoghi collettivi di aggregazione, soprattutto per i giovani, sostituiti dai centri commerciali e polifunzionali di intrattenimento, a cui in vario modo è delegata la gestione del tempo libero delle persone. La quotidianità finisce così, troppo spesso, per risolversi nell’ambito di relazioni di natura quasi esclusivamente funzionale: tra casa, scuola, lavoro, luoghi del consumo. Ma è sempre più evidente la richiesta di “luoghi terzi” – per citare il sociologo americano Ray Oldemburg – che non siano i centri commerciali dove vige la compulsione all’acquisto: la richiesta di luoghi “neutrali” e “sicuri” dove poter coltivare interessi conoscitivi di varia natura, e poter avere libere occasioni di incontro e di scambio con altre persone, diverse per età, cultura, ceto sociale, provenienza.
Nel progetto “Terzoluogo” le fragilità delle relazioni sono un punto di partenza e il rafforzamento di comunità che possano affrontarle è il punto di arrivo ideale. Concentrazione di povertà materiale ed educativa vuol dire anche diseguaglianza nelle opportunità di scoperta, accesso a quello che le città possono offrire, al livello personale e di gruppo. Gli spazi di questo centro culturale-educativo vogliono costituire dei nodi di circolazione per le sperimentazioni che avvengono in tutta la città, in un’ottica integrata e di mutuo apprendimento.
La nuova Biblioteca sarà al centro di una “piazza”: un luogo aggregativo accessibile, accogliente e conviviale che sappia costruire legami attivi tra le biografie e le esperienze lo attraversano, dove si possano sperimentare pratiche culturali, costruire relazioni sociali inedite, assemblare nuove identità.
Il nuovo centro avrà una particolare attenzione all’infanzia, in quanto è necessario ripensare i rapporti tra gestione genitoriale, familiare e comunitaria dell’infanzia, per far sì che le pratiche che riguardano la cura dei bambini divengano veicoli di coesione e inclusione per le altre generazioni, nonché strumenti per ripensare la dimensione del femminile e della maternità attraverso rapporti di cura più condivisi.
La progettazione delle funzioni e delle caratteristiche fisiche del centro culturale-educativo sarà il risultato di un processo site-specific basato sia sulle specificità degli edifici, sia su un percorso di ricerca e di ascolto costruito con gli abitanti e le organizzazioni del territorio.
In questo senso, il progetto “Terzoluogo” mira a costruire un ambiente di mutuo apprendimento nel quale armonizzare i saperi situati degli abitanti, l’esperienza e le competenze degli operatori, la collaborazione strutturata con università e centri di ricerca nazionali e internazionali.
FEDERICO SCARIONI, Fondazione per Leggere
Le competenze trasversali in biblioteca
In una società sempre più “fluida” e trasversale, è fondamentale che anche i luoghi di cultura come le biblioteche di pubblica lettura siano pervasi di trasversalità. Non solo nei servizi di base per il coinvolgimento di un pubblico sempre più eterogeneo ma, anche e soprattutto, nell’approccio e nella visione del personale che gestisce una biblioteca, in particolare di una biblioteca che voglia definirsi “sociale”. Mediamente un bibliotecario italiano dedica alle “attività per il libro” il 70% proprio tempo-lavoro. Il restante 30% del proprio tempo è rivolto ad altri servizi che sono comunque, seppur indirettamente, legati al libro stesso. Il tempo che va oltre le tradizionali attività di promozione alla lettura è molto poco. Attività come la progettazione, il coinvolgimento di partner esterni e la comunicazione, sono quasi inesistenti nell’orientamento formativo e, di conseguenza, nell’orizzonte mentale del bibliotecario. Questo è uno dei motivi per cui le biblioteche in Italia stanno perdendo la propria forza attrattiva, e il proprio pubblico, in una società che cambia rapidamente. Se il cambiamento non parte da un percorso formativo e di crescita del bibliotecario stesso, il cambiamento delle biblioteche si ferma. Tematiche come la gestione del conflitto, il rapporto con il gruppo di lavoro, la “narrazione” delle biblioteche, la creatività, l’intelligenza collettiva, la mediazione culturale e linguistica dovrebbero invece essere parte integrante del processo formativo e di crescita dei bibliotecari stessi. La trasversalità dei bibliotecari, nel 21° secolo, non è più un optional, ma è una necessità evolutiva che la professione dovrebbe condividere se desideriamo che le biblioteche non si trasformino in “cattedrali nel deserto”.
ARIANNA SPIGOLON, Fondazione Compagnia di San Paolo
Mille Culle: nutrirsi di cultura
A seguire: laboratorio in Sala Agnesi (per vedere il programma clicca qui)
-
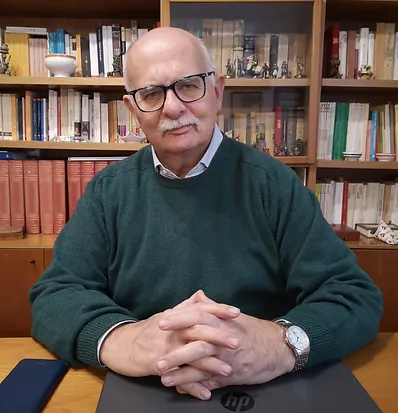
Ferruccio Diozzi
Consulente bibliotecario, già responsabile del Centro di documentazione del CIRA-Centro italiano ricerche aerospaziali
-

Chiara Faggiolani
Prof. Sapienza Università di Roma
-

Antonella Agnoli
Consulente per progettazione spazi culturali
-
Roberta Franceschinelli
Presidente Lo Stato dei Luoghi
-

Angelo Carchidi
Architetto e progettista culturale
-

Giuseppe Perna
Direttore della Biblioteca a porte aperte Annalisa Durante
-
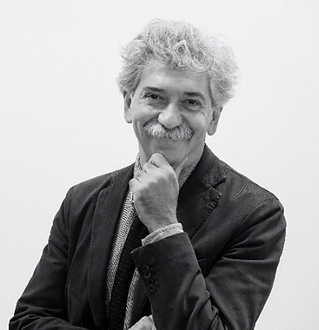
Roberto Di Puma
Consigliere di Amministrazione Fondazione Terzoluogo
-

Federico Scarioni
Direttore Generale Fondazione Per Leggere
-

Arianna Spigolon
Fondazione Compagnia di San Paolo