
Convegno delle Stelline – Torino
Indirizzo di saluto
FRANCESCA PAOLA LEON, Assessora alla Cultura del Comune di Torino
ROSA MAIELLO, Presidente Nazionale Associazione italiana Biblioteche
Coordina
STEFANO PARISE, Direttore Area Biblioteche del Comune di Milano
DAVID WEINBERGER, Senior Researcher at Harvard’s Berkman Klein Center for Internet & Society
Oracoli, biblioteche e Intelligenza Artificiale
Per secoli abbiamo avuto luoghi del sapere in cui andare per apprendere e conoscere. L’antica Grecia aveva gli oracoli. L’Occidente ha avuto le biblioteche. Oggi stiamo creando un nuovo tipo di luogo: i modelli di machine learning. Ogni luogo ha le sue caratteristiche: le previsioni degli oracoli erano vere ma non sempre comprensibili. Le biblioteche presentano la conoscenza sempre come un qualcosa derivante da e in conversazione con altra conoscenza. Ma i modelli di machine learning generano una conoscenza che può essere inspiegabile perché non c’è letteralmente nessuna conoscenza all’interno di questi modelli.
Forse sorprendentemente, la ristrutturazione culturale della conoscenza in termini di machine learning, che è già in corso, può creare nuove opportunità per le biblioteche di servire le loro comunità, sebbene le sfide non saranno facili da affrontare.
MAURIZIO VIVARELLI, Dipartimento di Studi storici, Università di Torino
MARCO MELLIA, SmartData@Polito Coordinator, Politecnico di Torino
Reading (&) Machine. Identità della biblioteca e Intelligenza Artificiale
L’intervento descrive le premesse, il contesto, ed alcune caratteristiche di fondo del progetto Reading(&)Machine, sviluppato in collaborazione tra centri SmartData@Polito e VR@Polito del Politecnico di Torino, Dipartimento di Studi storici dell’Università di Torino e Biblioteche Civiche Torinesi.
L’obiettivo del progetto è realizzare un ambiente innovativo in grado di rappresentare e arricchire l’esperienza della lettura, grazie all’azione di algoritmi di raccomandazione e di una specifica interfaccia, ed entrare a far parte della definizione di una diversa «identità», digitale e fisica, dello spazio della lettura in biblioteca.
Reading(&)Machine si basa sulla elaborazione del contenuto informativo dei dati prodotti dalle biblioteche, e di ulteriori tipologie di dati provenienti dalla piattaforma di social reading aNobii e da social network generalisti.
Reading(&)Machine, come esplicita il suo stesso nome, è dunque, in sintesi, una nuova configurazione di macchina per leggere, che può contribuire a valorizzare ruolo e funzioni delle biblioteche negli attuali scenari della ipermodernità.
GINO RONCAGLIA, Università Roma Tre
Quali piattaforme per la cultura?
Nell’ultimo anno, le necessità imposte dalla pandemia hanno portato – anche in ambito culturale – all’uso sistematico e diffuso degli strumenti di comunicazione on-line e in particolare delle piattaforme di videoconferenza. Strumenti che in questi mesi non solo sono diventati per molte e molti di noi un’abitudine quotidiana, ma che stanno anche conoscendo un rapidissimo sviluppo tecnologico e funzionale: gestione di gruppi e sottogruppi, gestione di contenuti e interventi multilingue anche attraverso meccanismi di trascrizione e traduzione automatica, funzionalità di ‘regia’ quasi televisiva degli eventi, sono solo alcuni fra gli esempi che si potrebbero fare.
Anche il mondo bibliotecario ha organizzato on-line moltissimi eventi, dalle presentazioni di libri ai gruppi di lettura, dagli incontri di formazione alle riunioni di lavoro. La centralità di questi strumenti – che speriamo possano tornare presto ad affiancare anziché sostituire gli incontri in presenza – non è un fenomeno passeggero: quando torneranno gli incontri fisici, sarà difficile non pensarli in forma almeno in parte nuova, con un uso maggiore dell’on-line sia come canale per la preparazione e il follow-up, sia come canale parallelo di diffusione, in grado di garantire un allargamento della partecipazione. Questa prospettiva pone però il problema della selezione delle piattaforme da usare e della progettazione delle loro funzionalità e delle loro interfacce, anche in funzione delle necessità del mondo della cultura e della mediazione informativa. Di che tipo di strumenti abbiamo bisogno, esattamente? Quali esigenze particolari e specifiche dobbiamo tenere presenti? L’intervento proporrà alcune considerazioni e alcuni suggerimenti su questo tema, con indicazioni pratiche anche sul legame con il mondo della scuola e della formazione e con le piattaforme per la didattica a distanza.
ROSSANA MORRIELLO, Servizio Programmazione Sviluppo e Qualità, Politecnico di Torino
Piattaforme bibliotecarie aperte e resilienti
La piattaforma è diventato il modello prevalente nella società odierna, alla base delle strutture sociali in cui viviamo, tanto che si parla di una “società delle piattaforme” e di “un ecosistema delle piattaforme”. L’idea della piattaforma è oggi prevalentemente associata al digitale ma in realtà è un modello per offrire servizi, commerciali e non commerciali, che esiste da ben prima di Internet e non riguarda solo il mondo digitale. Si tratta di modello basato sulla raccolta, sistematizzazione e trasformazione in valore dei dati, con una forte enfasi sulle relazioni: tra gli utenti, tra i produttori o le istituzioni e gli utenti, tra le stesse piattaforme. Un modello che ben si adatta alla natura relazionale della biblioteca e ai metodi gestionali “data-driven” che in misura crescente sono oggetto della pratica e della riflessione biblioteconomica. La relazione affronterà le modalità con le quali il modello della piattaforma può essere associato alle biblioteche, tenendo in considerazione le istanze sia di apertura sia di decentralizzazione del sistema delle piattaforme che stanno emergendo.
DISCUSSIONE
-
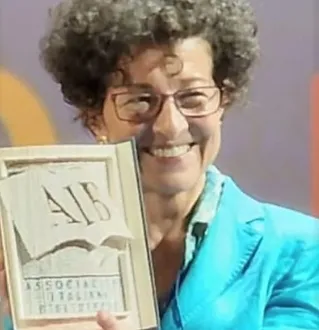
Rosa Maiello
Associazione italiana biblioteche; Università di Napoli Parthenope
-
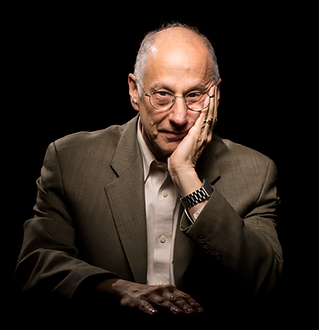
David Weinberger
Senior Researcher at Harvard’s Berkman Klein Center for Internet & Society
-

Maurizio Vivarelli
Già professore ordinario di Bibliografia e Biblioteconomia, Dipartimento di Studi storici, Università di Torino
-

Marco Mellia
SmartData@Polito Coordinator, Politecnico di Torino
-

Gino Roncaglia
Dipartimento di Filosofia Comunicazione Spettacolo, Università Roma Tre
-

Rossana Morriello
Università di Firenze, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo