
BIBLIOTECHE ACCADEMICHE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Introduce e coordina
MARISA SANTARSIERO, Direttrice Biblioteca e Archivi, Università Bocconi Milano
ROSSANA MORRIELLO, AIB Osservatorio biblioteche e sviluppo sostenibile (OBISS)
Le tre missioni dell’università per lo sviluppo sostenibile e il ruolo dei bibliotecari
Ricerca, didattica e terza missione delle università possono dare un contributo fondamentale al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. I bibliotecari accademici sono quindi chiamati a supportare le tre missioni istituzionali in diversi modi per il raggiungimento di tali Obiettivi.
GABRIELLA CALVANO, Vice-coordinatrice del GdL RUS “Educazione”, Università di Bari
Il ruolo dell’università per lo sviluppo sostenibile
La letteratura internazionale riconosce da anni il ruolo centrale che le Università hanno per lo sviluppo sostenibile globale e del territorio.
Anche gli Atenei Italiani, al pari di quanto avviene in altri Paesi, hanno deciso di intraprendere un cammino che le impegna a perseguire i Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 ed è un cammino che è in Rete e di Rete. Nel Luglio del 2016, infatti, la CRUI riconosce formalmente la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), un network che oggi conta 72 Atenei aderenti, in rappresentanza di tutte le Regioni d’Italia.
La RUS nasce con l’intento di diffondere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità, all’interno degli Atenei e nei territori di appartenenza, attraverso la condivisione di conoscenze, competenze ed esperienze sviluppate dalle Università che compongono la Rete.
L’impegno della RUS si sviluppa anche e soprattutto attraverso sei Gruppi di Lavoro nazionali, espressione di alcune aree tematiche che, nel cammino in vista della sostenibilità, risultano essere di particolare interesse per le Università del Paese: energia, cibo, rifiuti, mobilità, cambiamenti climatici, educazione.
L’approccio comunitario è fondamentale per costruire sviluppo sostenibile. Ce lo ricorda la stessa Agenda 2030 con un Goal specifico sulla Partnership (il diciassettesimo) e con la richiesta esplicita di creare connessioni e relazioni tra e per gli Obiettivi. Attraverso il lavoro comunitario, la RUS crea connessioni tra i differenti punti di vista di coloro i quali compongono la Rete, tra saperi scientifici e culturali apparentemente distanti e tra le diversità territoriali di chi la costituisce. E tutto questo concorre, definisce e amplifica il potenziale di sostenibilità della RUS stessa, attualmente impegnata a definire il Piano Attuativo del Manifesto dei Magnifici Incontri dello scorso maggio che costituirà un Programma di politiche e d’interventi tali che “nessuno venga lasciato indietro”.
DANILO DEANA, Direzione Servizio bibliotecario di ateneo, Università degli studi di Milano
Il viaggio dei sistemi bibliotecari di ateneo verso l’universo della performance (e ritorno)
Prima di chiedersi se le biblioteche accademiche possano diventare veicolo di promozione, visibilità e valorizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 adottata dalle Nazioni Unite, è necessario stabilire se esse stesse, nella loro dimensione aziendale, siano sostenibili, in grado cioè di creare valore attraverso i processi durevoli nel tempo, capaci di coinvolgere e remunerare i vari stakeholder che apportano risorse funzionali al successo dell’organizzazione” (Francesco Perrini, Management, Milano, 2016).
In tutte le istituzioni pubbliche convivono tre modelli che interagiscono tra loro: il modello politico, il modello legale e il modello aziendale. La riforma attuata dal ministro Brunetta attraverso il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e la sua successiva applicazione all’università con la legge Gelmini 30 dicembre 2010 n. 240 hanno avuto l’obiettivo di portare all’interno del modello aziendale della pubblica amministrazione i principi del new public management. Lo scopo del ciclo di gestione della performance previsto nel decreto era appunto di soddisfare le aspettative degli stakeholder attraverso il miglioramento continuo e l’innovazione. Ma i risultati sono stati quelli attesi? Per rispondere a questa domanda, è necessario esaminare i servizi delle biblioteche accademiche utilizzando gli stessi strumenti che si impiegano per le aziende. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile stabilire se esista un equilibrio tra i contributi richiesti alla collettività e i benefici ad essa garantiti.
MATTHIEU BORDET, International Development Manager, DM Cultura
I Learning Center come faro dello sviluppo sostenibile
Le biblioteche possono e devono svolgere un ruolo essenziale nel raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDGs) dell’agenda ONU. Con i loro compiti e le loro funzioni hanno un impatto significativo, in maniera diretta o indiretta, sulla maggior parte dei SDGs, elaborati con il contributo dell’ONU e sostenuti in modo deciso dall’AIB.
Questa constatazione è ancora più evidente laddove le progettualità partono dagli edifici stessi e dalla messa in discussione delle modalità di proposizione dei servizi. È questo il caso dei Learning Center, un’esperienza che supporta le biblioteche nel processo di cambiamento e di ridefinizione del loro ruolo, attraverso ambienti progettati su misura, dove nuovi spazi abbracciano nuovi servizi.
Il Learning Center corrisponde ad una concezione rinnovata di biblioteca, come luogo plurale di accesso alle risorse, di collaborazione, di apprendimento e di formazione, per la crescita culturale delle persone. Implica un ampliamento delle missioni documentarie, pedagogiche, sociali e culturali.
Negli ultimi venti anni sono nati tanti progetti di Learning Center, dapprima nei paesi anglosassoni e progressivamente nel mondo. Questo trend è recentemente emerso anche in Francia con numerose realizzazioni. A partire da alcuni casi nuovissimi, verranno presentati le caratteristiche principali e gli esempi virtuosi di sostenibilità (che in alcune realtà può apparire…insostenibile) che stanno rivoluzionando i servizi alla comunità con particolare riferimento alle università.
RAFFAELLA INGLESE, Biblioteca di Ingegneria e Architettura, Università di Bologna; CNBA-Coordinamento nazionale Biblioteche di Architettura
Ecodecaloghi e non solo: l’impegno costante del CNBA per la sostenibilità delle biblioteche
Il Coordinamento Nazionale delle Biblioteche di Architettura, nato per iniziativa di un piccolo gruppo di Bibliotecarie più di 40 anni fa, cresciuto moltissimo fino a oggi nel numero degli associati e delle attività, è sempre stato molto interessato allo sviluppo sostenibile. Il sito del CNBA www.cnba.it già da vari anni propone una sezione Green Library, dove possiamo trovare, tra le varie cose, materiale relativo a due importanti e recenti iniziative: il Convegno dell’ISPRA “L’ambiente in biblioteca, le Biblioteche per l’ambiente: reti e altre buone pratiche” e la 14a Giornata di Studio del CNBA “La biblioteca inForma: l’edificio, l’organizzazione e i servizi di una Green Library” e una sezione Bioarchitettura che riporta un accurato spoglio degli articoli della Rivista Bioarchitettura, completo di parole chiave e link ad alcuni articoli in full text, curato per noi dall’arch. Luca Ferrari. Alle Stelline Raffaella Inglese, architetto e bibliotecaria, Presidente del Coordinamento dal 2010 al 2016, parlerà di questo impegno costante del CNBA e illustrerà in particolare una iniziativa legata al Convegno dell’ISPRA: la redazione di due Decaloghi per favorire un comportamento corretto nei confronti dell’ambiente del Bibliotecario e dell’Utente.
MARIA ROSARIA CALIFANO, Direttore del Centro Bibliotecario di Ateneo, Università di Salerno
#Bibliounisa4DEV: buone pratiche di sostenibilità in una biblioteca accademica
La relazione intende illustrare come una biblioteca accademica, nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, possa contribuire concretamente al perseguimento dei SDg. Si illustreranno le pratiche messe in campo all’interno del progetto “Questa Biblioteca supporta gli SDG” : dall’analisi di contesto allo sviluppo di nuove procedure.
PAOLA COPPOLA, Biblioteca “Vilfredo Pareto”, Università degli studi Tor Vergata, Roma
Biblioteconomia circolare. Agire per il cambiamento
Nel novembre del 2015 l’Università di Roma “Tor Vergata”, ente fondatore dell’AsviS unitamente ad Unipolis, ha adottato lo sviluppo sostenibile come sua Missione e Visione, con la volontà di tradurre i nuovi principi sul piano della didattica, della ricerca e del rapporto con il territorio nel quadro concettuale disegnato dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
In questo contesto anche le biblioteche sono chiamate a vivere la sostenibilità in maniera integrata in tutte le loro funzioni e attività, impegnandosi ad alimentare un circolo virtuoso capace di coniugare i principi della sostenibilità sociale, economica, ambientale, con la creazione di valore a vantaggio del territorio, della comunità di riferimento e in genere degli stakeholders. In particolare la biblioteca Vilfredo Pareto della Facoltà di Economia è da anni impegnata in attività di public engagement, con l’intento di contribuire a tradurre in pratica il principio cardine dell’Agenda 2030: “che nessuno venga lasciato indietro”.
DEBORAH GRBAC, Biblioteca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Il contributo delle Biblioteche depositarie delle Nazioni Unite nella promozione degli SDG, tra tradizione e innovazione
Compito principale delle biblioteche depositarie delle Nazioni Unite è quello di informare la comunità locale sugli obiettivi, le attività, la documentazione e le fonti di informazione, così come di sostenere la ricerca, sulle questioni globali di interesse delle Nazioni Unite. Nel fare questo le biblioteche sono indirizzate e supportate dalle due Biblioteche delle Nazioni Unite a New York e a Ginevra.
La Biblioteca d’Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore fa parte da cinquant’anni del Sistema delle Biblioteche depositarie e si è recentemente confrontata, attraverso un progetto di ricostruzione filologica della collezione di pubblicazioni e di documenti ufficiali delle Nazioni Unite, sulla necessità di conciliare tradizione ed innovazione nel venire incontro alla comunità di studenti e di studiosi dell’Ateneo.
-

Marisa Santarsiero
Direttrice Biblioteca e Archivio, Università Bocconi Milano
-

Rossana Morriello
Università di Firenze, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo
-
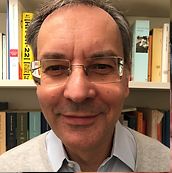
Danilo Deana
Direzione Servizio bibliotecario di ateneo, Università degli studi di Milano
-

Gabriella Calvano
Vice-coordinatrice del GdL RUS "Educazione", Università di Bari
-

Matthieu Bordet
International Development Manager, DM Cultura
-
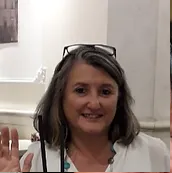
Raffaella Inglese
Biblioteca di Ingegneria e Architettura, Università di Bologna; CNBA-Coordinamento nazionale Biblioteche di Architettura
-

Maria Rosaria Califano
Direttore del Centro Bibliotecario di Ateneo, Università di Salerno
-

Paola Coppola
Biblioteca “Vilfredo Pareto”, Università degli studi Tor Vergata, Roma
-

Deborah Grbac
Biblioteca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano