BIBLIOTECHE OLTRE… OGNI ASPETTATIVA
Dal successo del trentennale delle Stelline una spinta a proseguire con nuovo impegno
Il 13 marzo si è chiusa la trentesima edizione del Convegno delle Stelline “Biblioteche oltre. I nuovi territori dell’interdisciplinarità”, ospitato per il secondo anno negli spazi di Palazzo Lombardia. Un anniversario importante, festeggiato nel migliore dei modi: 55 eventi, fra sessioni, tavole rotonde e workshop: più di 1.700 presenze registrate; 52 aziende partner; 1500 mq di tendostruttura arredata per accogliere gli stand e il prototipo di una biblioteca moderna.
Un successo che, prima di proseguire, ci induce a rivolgere un ringraziamento particolare a Regione Lombardia che ospitando l’evento ha contribuito in modo determinante al suo successo.


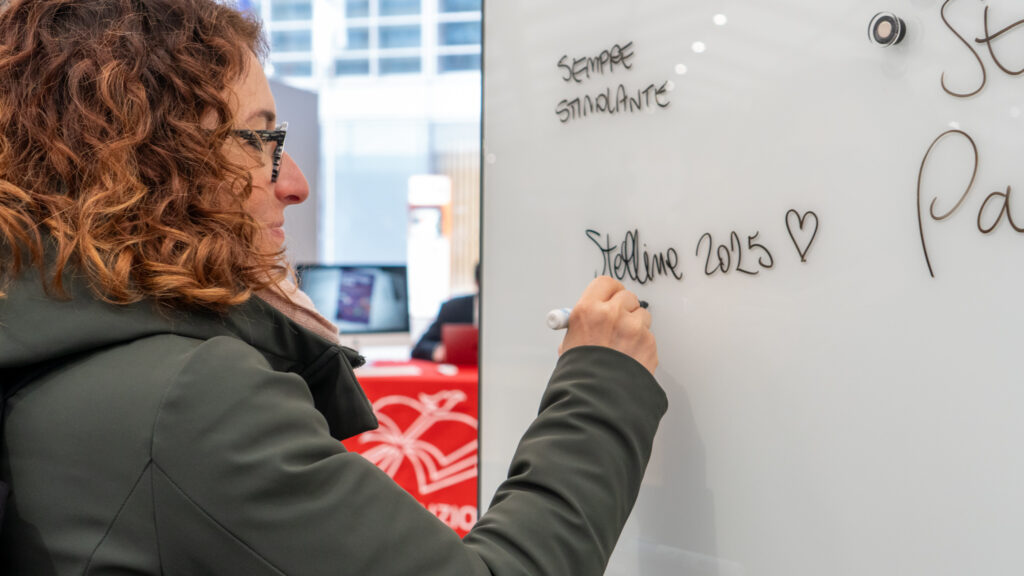
Le ragioni delle Stelline
È stata anche l’occasione per tentare un bilancio dei trent’anni delle Stelline individuando le ragioni del successo e della longevità di questo evento. Nel saluto di benvenuto di Massimo Belotti, Presidente dell’Associazione Biblioteche oggi APS, i principali motivi sono stati sintetizzati ricorrendo ad alcune parole chiave:
• TRENDS. Le Stelline hanno favorito e in qualche caso anticipato i processi di aggiornamento professionale, spostando di volta in volta il focus sui temi emergenti, nello sforzo di cogliere le tendenze senza inseguire le mode.
• CROCEVIA. Il Convegno ha saputo rivolgersi ai bibliotecari italiani nel loro insieme divenendone un punto di riferimento nazionale e un appuntamento fisso, ma avendo uno sguardo rivolto alla realtà internazionale ed esprimendo da sempre una vocazione internazionale.
• ACCESSIBILITÀ. Sin dalla sua prima edizione si è voluto che il convegno fosse aperto e liberamente accessibile senza che questa occasione di aggiornamento comportasse oneri per i partecipanti.
• ALLEANZE. Le Stelline hanno saputo contare sulla collaborazione di tutti: dalle istituzioni alle associazioni professionali, dagli istituti culturali alle aziende più qualificate di servizi divenute in larga parte sponsor.
• MOLTEPLICITÀ. Altro elemento di attrazione la possibilità per i bibliotecari di partecipare a sessioni di profilo scientifico integrate da numerose iniziative collaterali e workshop grazie a un palinsesto variegato, potendo contestualmente scoprire nella parte espositiva le proposte delle più qualificate aziende del settore.
• SOCIALITÀ ovvero un valore aggiunto. Le Stelline sono state uno straordinario momento di socializzazione, un’occasione di scambio, un appuntamento. Ci vediamo alle Stelline, ci ripetiamo già qualche mese prima. Il chiostro del Palazzo antico si prestava particolarmente all’incontro ma la Piazza che si è voluto allestire all’esterno di Palazzo Regione in occasione del trentennale voleva riproporre anche questa attitudine.
• PARTECIPAZIONE. Non si intende alludere all’alto numero dei partecipanti ma a un dato qualitativo: la scelta di introdurre da alcuni anni il metodo della coprogettazione che prevede che già alcuni mesi prima gruppi di lavoro di bibliotecari su base volontaria si impegnino nella definizione dei temi e dei contenuti programmatici.
Scenari e tendenze
L’occasione del trentennale ha indotto a focalizzarsi per l’edizione 2025 su un tema particolarmente avvertito e cruciale come quello della interdisciplinarità.
L’apertura ad altre discipline rappresenta infatti la nuova frontiera su cui sono chiamate a misurarsi le biblioteche, superando i tradizionali recinti disciplinari per arricchire la loro progettualità grazie ad altre competenze, suggestioni e confronti.
Quattro sono state le sessioni principali, di valore scientifico e profilo internazionale che si sono svolte a Palazzo Lombardia nelle due giornate approfondendo il tema.
Di particolare importanza la sessione inaugurale, coordinata da Sabrina Sammuri, Direttore generale Cultura di Regione Lombardia, che si è svolta la mattina di mercoledì 12 marzo. Dopo gli indirizzi di saluto delle autorità, il filosofo Roberto Casati, nella sua prolusione, ha sostenuto che una teoria transazionale e funzionale degli scambi tra discipline potrebbe aiutarci a ripensare l’interdisciplinarità mostrando come le discipline non verrebbero dissolte, ma piuttosto rafforzate.
È toccato a Maurizio Vivarelli calarsi nello specifico proponendo anche attraverso casi di studio una concezione della interdisciplinarità applicata alla biblioteconomia e alla pratica delle biblioteche in grado di far loro compiere un salto di qualità.
Esempio particolarmente efficace di interdisciplinarità è quello che è stato illustrato da Marie Østergård, direttrice della celebre biblioteca Dokk1 di Aarhus, che ha dimostrato come l’obiettivo strategico della biblioteca è di proporsi come infrastruttura della democrazia attraverso la pratica della co-creazione e il coinvolgimento della comunità.
È stata quindi la volta di Chiara Faggiolani che, dopo essersi soffermata sull’importanza delle future sciences anche per le biblioteche, ha teorizzato che il bibliotecario ha tutte le caratteristiche per qualificarsi come link maker, un professionista capace di attivare connessioni tra persone, saperi e territori, un architetto di esperienze culturali e catalizzatore di comunità.
Ospite d’onore della mattinata Melania Mazzucco, una delle scrittrici più affermate nel panorama italiano, che ha raccontato alcuni aneddoti curiosi tratti dalla sua esperienza di frequentatrice assidua di biblioteche. A conclusione della mattinata un fuoriprogramma applaudito: la consegna da parte dell’Associazione degli editori sardi del Premio Lorem ipsum che ogni anno viene assegnato a chi si è particolarmente distinto nella filiera del libro. Vincitrice dell’ultima edizione è risultata una bibliotecaria molto popolare e cara a noi tutti: Maria Stella Rasetti. La sede per la proclamazione non poteva essere più adatta.



Biblioteche al bivio
Nel pomeriggio, una delle principali sessioni, coordinata da Stefano Parise e aperta da Mikkel Christoffersen, COO Danish Library Association, si è interrogata se interdisciplinarità vada intesa per le biblioteche come acquisizione di “altre” competenze o come capacità di interagire con “altre” professioni, superando la logica dei silos che non comunicano.
Di particolare interesse a questo riguardo l’intervento di Luca dal Pozzolo Dai silos delle discipline ai territori della conoscenza. Le biblioteche tra interazione, dialogo e cittadinanza in cui non ha risparmiato critiche alla logica della verticalità ancora imperante in molte biblioteche, sostenendo la necessità di assumere un’ottica in cui si apra una maggior percorribilità anche orizzontale dei saperi.
Guardando oltre, verso i nuovi territori, Annalisa Cicerchia ha sostenuto che le biblioteche sempre più saranno destinate a integrarsi nel sistema del welfare e che uno dei tratti qualificanti della loro missione risiederà nella capacità di contribuire al benessere e alla salute.
Per Carlo Bianchini invece l’interdisciplinarità deve misurarsi con la complessità, che è una qualità intrinseca della biblioteca: per poter offrire servizi rilevanti, accessibili e incentrati sugli utenti, la complessità della biblioteca e delle sue relazioni deve essere studiata, analizzata e interpretata necessariamente attraverso un approccio interdisciplinare.
Gli ultimi due interventi della sessione si sono proposti di considerare l’interdisciplinarità alla luce dell’evoluzione tecnologica: Fabio Cusimano attraverso un excursus storico dall’analogico al digitale, mentre Anna Maria Marras ha esplorato le sinergie tra il mondo digitale e le istituzioni culturali (musei, archivi e biblioteche) per favorire intrecci e relazioni in una prospettiva di integrazione.
Le discipline del bibliotecario
La seconda giornata è stata aperta da una sessione coordinata da Paola Castelluccci, Presidente della Società italiana di studi bibliografici e biblioteconomici, che ha visto accademici confrontarsi sul ruolo della biblioteconomia nella ricerca di un riposizionamento di questa disciplina, da sempre punto di riferimento per i bibliotecari, e di una sua apertura nei confronti di altre discipline. Il che ha creato le condizioni, specularmente, per un approfondimento dedicato alla formazione del bibliotecario oggi. Nondimeno ha offerto la possibilità di un confronto dialettico con le aspettative dei bibliotecari espresse dalla Presidente dell’AIB Laura Ballestra, che nel suo intervento, rivolta a chi ha compiti di formazione, ha disegnato il profilo della figura del bibliotecario del futuro.
Due professori emeriti molto conosciuti e apprezzati nel mondo delle biblioteche, Mauro Guerrini e Giovanni Solimine, hanno aperto i lavori.
Guerrini ha riaffermato il primato della biblioteconomia sostenendo che la disciplina così come la figura del bibliotecario sono cambiate radicalmente negli ultimi venti anni, mantenendo la loro identità e vitalità proprio perché stanno evolvendosi con lo sviluppo della ricerca, dei bisogni informativi, delle nuove opportunità tecnologiche.
Giovanni Solimine, con Il terzo tempo della biblioteconomia, ha preferito partire da un’analisi critica della situazione delle biblioteche per sostenere la necessità di una biblioteconomia che sappia rispondere a un contesto sociale in trasformazione.


Negli ultimi decenni del Novecento si è passati da una disciplina centrata essenzialmente sui documenti e sulla loro descrizione a una disciplina che, per rispondere all’urgente richiesta di una maggiore efficacia che veniva rivolta alle amministrazioni pubbliche, si è orientata maggiormente verso la progettazione, la gestione e la valutazione dei servizi. Nella fase attuale si nota una attenzione alla reinterpretazione del ruolo che le infrastrutture bibliotecarie possono esercitare nei processi di welfare culturale, di coesione e inclusione sociale e di rigenerazione urbana.
Alberto Salarelli e Maria Alessandra Panzanelli hanno riportato i primi risultati di un’indagine nazionale, realizzata con la collaborazione di Simona Turbanti, sulla situazione della didattica nel panorama universitario italiano. Scopo di questa mappatura, fra l’altro, quello di evidenziare il livello di posizionamento delle discipline del libro e del documento in un’ottica interdisciplinare.
Francesca Tomasi ha dimostrato come il sapere ibrido rappresentato dalle Digital Humanities può aprire nuove prospettive nella formazione dei bibliotecari: un sapere che coniuga metodologie computazionali nel trattamento dei dati con il bagaglio storico-conoscitivo delle discipline umanistiche, in particolare delle scienze del libro e del documento.
La lettura digitale in biblioteca
Sulla scia dei buoni esiti della sessione dedicata ai “numeri” nell’ultima edizione (nel 2024 sono state le cifre della lettura, tema di quel convegno) si è tenuta anche nel 2025 una sessione, coordinata da Chiara Faggiolani, dedicata ai numeri, in questo caso ai numeri della lettura del digitale nelle biblioteche e alla loro misurazione.
Come sostenuto da Faggiolani “il digitale viene spesso percepito attraverso uno stereotipo riduttivo e negativo: frammentato, isolante, superficiale e non adatto a stimolare la complessità. Questa visione rischia di oscurare il reale potenziale della lettura digitale e dei servizi digitali offerti dalle biblioteche. La sessione ha voluto affrontare proprio questa contraddizione esplorando il fenomeno della lettura digitale, spesso invisibile o sottovalutata, e dimostrare come essa contribuisca alla ridefinizione dei modelli di performance delle biblioteche. Esperti di statistica (Bologna e Federici di ISTAT) e di associazioni di categoria (Peresson di AIE), operatori del settore (Blasi di MLOL), esperti bibliotecari (Gussago dei servizi automatizzati della Provincia di Brescia) hanno riportato i risultati di indagini sul campo e accurati rapporti annuali. Di particolare interesse lo sguardo internazionale introdotto da Fabio Mercanti e il suo riferimento a progetti e metodologie in corso di sperimentazione per la “misurazione” dei numeri del digitale. Infine va citato per il grande interesse suscitato l’intervento di Federico Badaloni (Gruppo GEDI) che ha dimostrato come la questione da cui partire per far entrare le biblioteche nella nostra epoca non è tecnologica ma culturale.

La coprogettazione
Grazie alla formula partecipativa, ormai consolidata, che ha visto bibliotecari di diversa provenienza confrontarsi attraverso tavoli di lavoro avviati mesi prima si sono svolte in contemporanea sessioni parallele, più agili e più brevi nella durata ma di non minore interesse.
Ne riportiamo i titoli/temi con l’indicazione dei rispettivi coordinatori:
1.Transdisciplinarità e collezioni delle biblioteche: analisi e ricerche applicate (Sara Dinotola).
2. Intersezioni AI: biblioteche e discipline diverse, in dialogo. Esplorando nuovi scenari collaborativi grazie all’intelligenza artificiale (Anna Busa).
3. Bibliotecari oltre. Attitudine alla transdisciplinarità e competenze collettive (Maddalena Battaggia).
4. Promuovere l’Open Access: una sfida per le biblioteche nell’era dell’interdisciplinarità (Benedetta Calonaci).
5. Biblioteche e rigenerazione urbana (Antonella Agnoli).
6. Mettere le persone al centro delle biblioteche digitali: un percorso basato sull’interazione (Anna Maria Tammaro).
7. Indisciplinati, un gioco da ragazzi! (Giuseppe Bartorilla e Gabriella Marinaccio).
8. Il bibliotecario come educatore (Patrizia Luperi).
9. Biblioteche e linguaggi audiovisuali (Anna Fiaccarini).
Accanto alle sessioni, che costituivano l’ossatura del palinsesto, non possiamo tuttavia dimenticare che il programma ha visto susseguirsi numerosi altri incontri, workshop, presentazioni, dibattiti, laboratori, che hanno reso il trentennale delle Stelline un evento eccezionale per il nostro settore.






Le Stelline in Piazza
Ed eccezionale è stata la grande tendostruttura realizzata in Piazza Città di Lombardia, molto frequentata, una sorta di “biblioteca ideale” dove è stato possibile tenere incontri e favorire momenti di socializzazione, oltre a prendere visione di un’ampia gamma di soluzioni di arredo e servizi, entrando in contatto con le più qualificate aziende del settore, alle quali va il nostro ringraziamento per aver sostenuto il convegno in qualità di sponsor.



Un ponte verso l’Europa
Va infine segnalata un’iniziativa di carattere internazionale che ha anticipato di un giorno l’inizio del Convegno delle Stelline. Martedì 11 marzo infatti si è tenuta sulla suggestiva Terrazza Belvedere di Palazzo Lombardia il seminario Waiting for Next Library 2025 che aveva lo scopo di promuovere presso la comunità professionale dei bibliotecari italiani la partecipazione al Next Library Festival, contribuendo a fidelizzarla rispetto al circuito internazionale scandito dai due importanti eventi, ad anni alterni, di Next Library e Occupy Library. Per l’occasione è stata presentata una rassegna di idee e case history proposte da biblioteche italiane, di cui quella che è stata giudicata migliore dalla giuria – illustrata da Elisabetta Bovero, dirigente della biblioteca di Cesena – potrà partecipare alla prossima edizione di Next Library a spese dell’Associazione Biblioteche oggi APS.