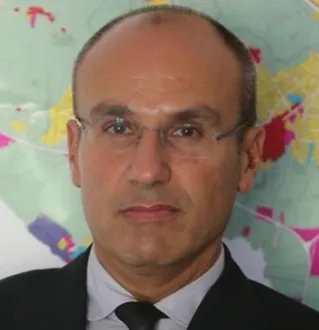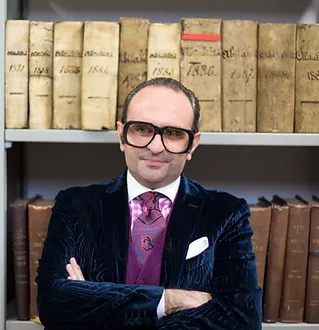LE FORME DELLA COLLABORAZIONE FRA PUBBLICO E PRIVATO. Dal diritto alle pratiche: modelli, strumenti, esperienze
Sessioni a cura dei gruppi di lavoro con il coordinamento della direzione scientifica
Introduce e coordina
ANNALISA ROSSI, Soprintendente agli archivi e alle biblioteche della Lombardia, del Veneto e del Trentino Alto Adige
- Testimonianze: dalle esperienze professionali alla mappa dei problemi
MARCO CHIANDONI, Biblioteca comunale Staranzano
Si riportano, ai fini di una discussione più generale, alcune criticità rilevate in qualità di bibliotecario di ente locale di dimensione medio-piccola in merito alla possibilità di stabilire forme di partenariato pubblico-privato
ROSELLA MANCINI, Società AB-archivibiblioteche srl
Partendo da una breve valutazione dei vantaggi legati all’applicazione del Partenariato Pubblico Privato, si passa ad un rapido confronto con lo strumento dell’ appalto pubblico, e si sollecita una riflessione sulle condizioni reali in cui operano gli enti locali di pubblica amministrazione, in particolare legati alla valorizzazione e gestione dei beni culturali con alcuni esempi. Tre domande aperte chiudono la riflessione.
- Fra diritto, teoria e prassi: dai beni comuni al Partenariato Pubblico Privato
Patrimonio culturale e comunità: i beni comuni nel diritto internazionale e nazionale. Sguardi dall’Europa all’Italia
LUISELLA PAVAN WOOLFE, Head of Council of Europe in Venice
FRANCESCO TRAMONTANA, Segretario generale Città di Varese
La definizione storicizzata di bene culturale, recepita per lo più stabilmente nelle codificazioni amministrative, tra cui il Codice Urbani, tende ad affrancare i suoi contorni morfologici dall’assetto proprietario. L’attenzione è infatti rivolta alla funzione del bene e non al suo regime dominicale, sicché – in un’accezione ampia e per alcuni versi provocatoria – i beni culturali possono essere definiti come adespoti. E ciò non già in quanto privi di una propria collocazione entro la sfera dispositivo-patrimoniale del soggetto che li detiene stabilmente in forza di un titolo proprietario. Ma poiché la loro funzione acquista connotati dal carattere ontologicamente così collettivo da travalicare lo statuto dispositivo tipico del diritto di proprietà e partecipare a un regime più ampio, sfumato e di incerta codificazione normativa, qual è quello dei beni comuni.
Ascritta al pensiero di Elinor Ostrom, la categoria dei beni comuni è solitamente ricondotta a una tassonomia articolata attraverso scenari di forte impronta naturalistica (valli di pesca, boschi, pascoli) in cui la gestione degli elementi bio-essenziali che li compongono (tra questi l’acqua) costituisce l’elemento più fortemente caratterizzante.
Tuttavia, alcuni loro predicati tipici (la prevalenza della funzione collettiva sulla proprietà escludente, il loro utilizzo tendenzialmente rivale) hanno portato a estendere la sfera di influenza di questa nuova idea di bene avulso dal contesto dominicale alla categoria, apparentemente più strutturata, dei beni culturali.
Il contributo muove da questo assunto, per declinare il genus dei beni comuni e provare a dare una risposta sulla plausibilità della riconduzione a esso della species dei beni culturali.
Il PPP come strumento innovativo per la gestione della transizione digitale dei servizi del Comune di Milano
FRANCESCO MARTELLI – SERGIO ALDARESE – DORA LANZETTA
L’esperienza del comune di Milano nella gestione delle pratiche di edilizia: dall’applicazione dell’archivistica ai fondi edilizi fino all’ esternalizzazione dei servizi di consultazione
- Tavola rotonda
Testimoni e Relatori interagiscono con i discussant su una traccia condivisa
GIUSEPPE COSENZA, Invitalia – analista finanziario
l partenariato speciale pubblico privato previsto dall’art. 151 comma 3 del Codice dei contratti pubblici del 2016 consente soluzioni innovative, semplificate e diversificate di conservazione e di valorizzazione di beni culturali immobili. Tale strumento supera la rigidità tradizionale del regime concessorio e permette forme elastiche di collaborazione, anche strutturate e a medio-lungo termine, mediante la creazione di organismi comuni, modalità di governance flessibili e modelli di business innovativi. Trascorso un periodo di sperimentazione strutturale della durata di circa cinque anni dalla entrata in vigore della norma, il 2021 e soprattutto il 2022 sono stati anni di applicazione concreta che hanno visto nascere progetti in capo al Ministero della Cultura di natura diversa sotto gli aspetti degli enti promotori e dei destinatari. Si pensi agli avvisi pubblicati dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei, dalla Reggia di Caserta e dalla Direzione Regionale Musei della Calabria, ognuno dei quali differenti per oggetto, finalità e destinatari, rispettivamente rivolti a enti del terzo settore o a imprese tradizionali. Invitalia nel 2021 ha svolto attività di advisoring per il Ministero della Cultura in tutte le attività di Program Management e di Centrale di Committenza per la riqualificazione energetica del Museo e Real Bosco di Capodimonte. L’operazione di finanza di progetto in cooperazione con soggetti privati, in proiezione futura dovrebbe avere tra i principali risultati risparmi sia in termini di costi, sia in termini di consumi energetici. Nei prossimi anni si dovrebbe avere una maggiore diffusione dello strumento giuridico tra i diversi istituti e luoghi della cultura e una sperimentazione anche verso forme di partenariato aventi ad oggetto la gestione congiunta di beni culturali materiali e digitali. Il partenariato potrebbe essere lo strumento flessibile grazie al quale si creano modelli di business innovativi e ibridi.
ALESSANDRO LORICA, Direttore Generale DM Cultura
Tavola rotonda su: Le forme della collaborazione fra pubblico e privato Dal diritto alle pratiche: modelli, strumenti, esperienze